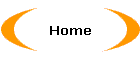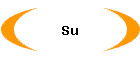Le foreste pluviali, presenti nel bacino dello Zaire, nell’Amazzonia, nell’America Latina settentrionale (Guyana) e nella Nuova Guinea, fanno le spese di una malintesa bonifica agraria o, più spesso, di evidenti speculazioni: in Brasile per esempio nel solo 1987 nel giro di quattro mesi, da luglio ad ottobre, sono stati incendiati 50.000 chilometri quadrati di territorio appartenente a quattro stati della regione amazzonica (l’Acre, il Mato Grosso, il Parà e quello di Rondonia). L’anno dopo è stata distrutta un’analoga quantità di foresta. Queste foreste dagli alberi immensi e centenari, asilo di migliaia di specie di animali e produttrici di una gran parte dell’ossigeno della Terra, sorgono su terreni che si sono rivelati poverissimi passando all’uso agricolo: ciononostante il loro disboscamento procede con ritmi sempre più rapidi, rendendoli tra gli ambienti più minacciati del globo. Le foreste pluviali, inoltre, sono tra i biomi più ricchi per numero di specie e quindi per varietà biologica (ospitano almeno la metà delle specie terrestri esistenti per un totale di 5 milioni, benché ricoprano solo il 6% delle terre emerse).
Alla distruzione di questi ambienti vergini si accompagna l’estinzione di numerose piante e animali, a un ritmo che è aumentato vertiginosamente negli ultimi decenni. L’esistenza di piante e animali, invece, è preziosa per motivi non soltanto estetici e morali, ma anche economici e scientifici, cioè per il loro contributo all’agricoltura, all’industria, alla medicina, alla biologia e alla conoscenza in generale.
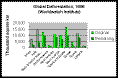 La
salvaguardia delle specie selvatiche fa oggi parte dei programmi di quasi tutti
i governi: circa il 4 % delle terre emerse sono protette e ben pochi paesi sono
privi di parchi naturali. Tuttavia l’aumento della popolazione costituisce una
grave minaccia per la politica di conservazione perseguita da molti paesi in via
di sviluppo: in Kenia il 6% del territorio è tutelato (con vantaggio anche
economico per via del turismo), ma i parchi sono minacciati dalla crescita degli
abitanti, che invadono i terreni protetti per coltivarli; anche il turismo
contribuisce a distruggere il territorio. Lo stesso accade in Uganda, Etiopia e Zimbabwe. Anche in altri paesi
con una popolazione contadina in espansione (Brasile, Colombia, Perù, Costa
d’Avorio, Madagascar, Indonesia, Filippine e Thailandia) le terre vergini
vengono distrutte dagli agricoltori; ancora più dannoso delle coltivazioni è
l’allevamento, soprattutto ovino e caprino, che trasforma i boschi in veri e
propri deserti.
La
salvaguardia delle specie selvatiche fa oggi parte dei programmi di quasi tutti
i governi: circa il 4 % delle terre emerse sono protette e ben pochi paesi sono
privi di parchi naturali. Tuttavia l’aumento della popolazione costituisce una
grave minaccia per la politica di conservazione perseguita da molti paesi in via
di sviluppo: in Kenia il 6% del territorio è tutelato (con vantaggio anche
economico per via del turismo), ma i parchi sono minacciati dalla crescita degli
abitanti, che invadono i terreni protetti per coltivarli; anche il turismo
contribuisce a distruggere il territorio. Lo stesso accade in Uganda, Etiopia e Zimbabwe. Anche in altri paesi
con una popolazione contadina in espansione (Brasile, Colombia, Perù, Costa
d’Avorio, Madagascar, Indonesia, Filippine e Thailandia) le terre vergini
vengono distrutte dagli agricoltori; ancora più dannoso delle coltivazioni è
l’allevamento, soprattutto ovino e caprino, che trasforma i boschi in veri e
propri deserti.
In modo molto approssimativo, la riduzione dell’area delle foreste pluviali tropicali, al tasso attuale, implica l’estinzione annuale, o quanto meno la condanna all’estinzione, di circa lo 0,5% delle specie della foresta.
Alcuni studi condotti nelle foreste indicano che la biodiversità accresce la capacità degli ecosistemi di trattenere e conservare i nutrienti. Quando vi sono molte specie vegetali, l’area fogliare è distribuita in modo più uniforme; cioè col crescere del numero delle specie cresce la gamma di foglie e di radici specializzate, e quindi aumenta la quantità di nutrienti che la vegetazione nel complesso può estrarre da ogni recesso e in ogni ora del giorno e durante tutte le stagioni.
L’ecologia delle foreste pluviali è in netto contrasto con quella delle foreste e delle praterie, tipiche dei climi temperati settentrionali. Nel Nord America e nell’Eurasia, la materia organica non è immobilizzata in modo così completo nella vegetazione vivente. Gran parte di essa giace relativamente inutilizzata nello spesso strato di detriti e di humus del suolo. I semi sono più resistenti agli stress e sono in grado di rimanere quiescenti per lunghi periodi, fino a quando, cioè, non si instaurino le condizioni di temperatura e di umidità più favorevoli. Ecco perché è possibile tagliare e bruciare grandi appezzamenti di foresta e di prateria, allevare bestiame, coltivare raccolti per anni e anni, e poi assistere, nel giro di un solo secolo da che quel territorio è stato abbandonato a se stesso, al ritorno quasi completo della vegetazione originaria. Si può dire che, su scala planetaria, il nord sia più fortunato del sud.
Le cause principali della deforestazione continuano ad essere l’agricoltura su piccola scala, e soprattutto la coltivazione che, basata sulla tecnica dell’abbattimento e dell’incendio, favorisce gli insediamenti stabili a scopo agricolo. Meno dannose, ma non di molto, sono le attività commerciali di sfruttamento del legname e di allevamento degli animali da pascolo.
Gli incendi appiccati nell’Amazzonia per ripulire il terreno dagli alberi morti e dagli arbusti hanno determinato un inquinamento a livello planetario. Questi incendi brasiliani hanno generato anidride carbonica per un totale di 500 milioni di tonnellate di carbonio, 44 milioni di tonnellate di monossido di carbonio, più di 6 milioni di tonnellate di particelle sospese, e 1 milione di tonnellate tra ossidi d’azoto e altri inquinanti. Molto di quel materiale ha raggiunto gli strati superiori dell’atmosfera e si è trasferito verso est, in forma di pennacchio, attraverso l’Atlantico.
Per capire che impatto ha questo genere di distruzione sulla biodiversità delle foreste tropicali, per ipotizzare quale sia ragionevolmente il tasso minimo di specie passibili di estinzione, dobbiamo prendere in considerazione dei modelli che riproducano il rapporto esistente fra area degli habitat e numero delle specie che li popolano.
Gli ecosistemi tendono a rimanere stabili nel tempo a causa del grande numero di diversi organismi e di connessioni tra gli organismi stessi, che li caratterizzano. Generalizzando possiamo dire che più è alto il numero di organismi diversi e, quindi, di legami nella catena alimentare, più è stabile la comunità. Una grande comunità è composta da tante specie e così, se una di queste specie scompare, la comunità continua a funzionare normalmente: se una malattia decima i conigli che vivono in una comunità, le volpi possono nutrirsi di topi o di scoiattoli fino a che i conigli si riproducano o immigrino nella comunità. Anche se molti conigli sono morti, il resto dell’ecosistema è rimasto intatto: la comunità ha subito dei cambiamenti ma non è stata distrutta grazie a quel processo chiamato omeostasi.
L’uomo può però subentrare all’interno di un ecosistema alterandone l’equilibrio con effetti positivi su alcuni membri della comunità o con effetti drammaticamente negativi. Ne è un esempio l’agricoltura che distrugge molti componenti di una catena alimentare quando si coltivano prodotti che debbono soddisfare le esigenze umane. Per fornire gli alimenti necessari alla popolazione umana, si coltivano grandi appezzamenti di terreno, i quali, per utilizzare in modo efficiente le macchine agricole, vengono adibiti ad una stesso prodotto (monocultura). Un solo campo di grano può misurare 16 ettari; esso contiene 76000 piante e produce 7258m3 di grano. In una normale rete alimentare queste piante di grano fornirebbero energia ad un grande numero di consumatori: uccelli, insetti ed animali che si nutrono di uccelli e di insetti. Uccelli ed insetti che si nutrono di grano e competono con gli esseri umani per nutrirsene, vengono eliminati assieme alle piante che competono con il grano per luce, acqua e sostanze nutritive. Un così gran numero di piante di grano fa aumentare il rischio di diffusione di malattie come parassitosi, ecc. Se l’agricoltore coltiva grano con criteri di economicità, per fornire cibo alla popolazione umana, deve controllare la rete alimentare ed eliminare animali nocivi e malattie. Spesso questo controllo implica l’irrorazione, su larga scala, delle colture, con sostanze di sintesi che possono avere effetti collaterali imprevedibili.
Gli esseri umani soffrono di malattie causate da parassiti, come la malaria e la malattia del sonno. Poiché queste malattie possono causare molti morti e perdita di ore lavorative, si è cercato di eliminare gli insetti che le causano. Un sistema per controllare gli insetti dannosi è quello di usare delle sostanze velenose per eliminarli. Queste sostanze sono chiamate insetticidi, erbicidi e fungicidi. Tutte possono essere incluse nel termine biocidi. Gli Stati Uniti, da soli, producono più di 636 milioni di Kg di biocidi all’anno.
Se la gara per il salvataggio della biodiversità dovesse essere persa, dovremmo rassegnarci alla scomparsa di tutti gli ecosistemi esistenti. Ecco, allora, che sono stati raccolti campioni di alcuni microrganismi e congelati in un bagno di azoto liquido in una totale inattività biochimica così da poter essere riscaldati e riattivati in ogni momento. Questo processo potrebbe essere esteso a tutte le specie ma se si dovesse dare alloggio in “banche dei semi” a tutte le specie, ciò coinvolgerebbe decine di milioni di specie di cui la maggioranza è ancora del tutto ignota alla scienza; inoltre, forse, nel momento di restituire la specie al proprio ambiente selvatico, la base fisica dell’ecosistema potrebbe essere mutata mettendo, così, in dubbioi risultati di tanto lavoro.