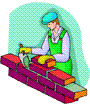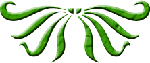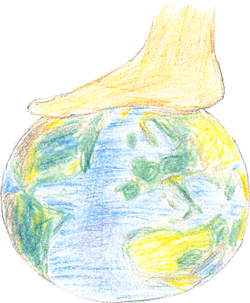Capire cosa costituisce un'attività umana sostenibile è essenziale per ogni studio di politica di formazione ambientale e costituisce anche il soggetto di continui dibattiti a livello nazionale ed internazionale.
Alcune organizzazioni ambientaliste si prefiggono la meta di tornare a un ambiente "naturale", come quello precedente lo stanziamento umano. Nella maggior parte delle aree abitate dagli esseri umani, tuttavia, tale ritorno non può verificarsi senza distruggere le infrastrutture fisiche ed il tessuto sociale.
L'agricoltura, l'attività mineraria, la pesca, la selvicoltura, l'industria, i trasporti e le costruzioni provocano grandi mutamenti, talvolta irreversibili, all'ambiente. Poiché il ritorno all'ambiente "naturale" è, nella maggior parte dei casi, una meta utopica, bisogna concentrarsi sullo sviluppo "sostenibile" - cioè, un tipo di sviluppo che può essere mantenuto indefinitamente senza effetti nocivi sull'ambiente, assicurando, così, che il pianeta sarà in grado di ricevere le future generazioni.
Agenda 21
Secondo l'Agenda 21: "Sviluppo sostenibile significa più della semplice sostenibilità ecologica […]. Lo sviluppo sostenibile non è compatibile con la povertà, la mancanza di diritti umani e di libertà, l'ignoranza o l'emarginazione culturale, economica, politica o etnica. E ciò non solo perché la soluzione di questi problemi sociali implica un imperativo etico, ma anche perché tali problemi arrestano la creatività, il progresso tecnico, e la formazione del capitale necessario per uno sviluppo sostenibile. Per questo, l'educazione e la formazione per uno sviluppo sostenibile non significa solo educazione all'ambiente, benché quest'aspetto sia incluso".
L'educazione e la formazione per uno sviluppo sostenibile devono, perciò, essere indirizzate all'intera popolazione e devono coniugare scienza e tecnologia con etica e sviluppo sociale.