Introduzione
L'articolo che segue è parte di una serie di lezioni proposte agli studenti delle classi terminali del Liceo Scientifico "G. Torelli" di Pergola, rielaborate per renderle più complete e pubblicate in un volumetto che racchiude altri interventi sul Paesaggio delle Marche. Uno di questi interventi ha riguardato la fauna delle Marche in particolare uccelli e i mammiferi. Nel presente lavoro vengono presentate alcune notizie storiche sulla fauna ornitica della Regione e per le specie più minacciate anche lo status attuale oltre che la check-list. In un prossimo lavoro si parlerà di mammiferi e a conclusione verrà tentata una riflessione sull'uso anche didattico dei dati raccolti nelle check-list. La fauna delle Marche ha origini lontane, sia nel tempo che nello spazio, in parte derivanti dalle vicende biogeografiche, cioè spostamenti di elementi faunistici da altre regioni geografiche, in parte da vicissitudini storiche che hanno coinvolto nei secoli il territorio regionale. Tra gli elementi paleogeografici che hanno determinato grande influenza sulla formazione della fauna appenninica un ruolo centrale è stato svolto dalla formazione stessa della Penisola Italiana con spostamenti di microplacche da Ovest e successiva orogenesi appennica. Un secondo processo geologico è stato la grande crisi di salinità occorsa al Mediterraneo nel Miocene superiore, Messiniano, con forte abbassamento del livello marino che ha messo in comunicazione gran parte delle terre allora emerse. Terzo elemento fondamentale è costituito dalle sei imponenti glaciazioni con le relative fasi calde interglaciali che hanno sospinto faune diverse da aree geografiche anche molto distanti. E' evidente che risulta estremamente difficile occuparsi della fauna marchigiana estrapolandola dal contesto appenninico se non addirittura europeo.

Alcune note storiche
Oltre alle glaciazioni, ai fenomeni orogenetici, alle fluttuazioni del livello marino ecc., la fauna marchigiana ha dovuto fare i conti con l'uomo, che ha modificato radicalmente il territorio. L'uomo, infatti, da quando è passato da semplice cacciatore e raccoglitore, a produttore ha introdotto nuove specie vegetali, addomesticato animali, diboscato, ha in generale modificato sensibilmente le caratteristiche del territorio. Tali trasformazioni hanno avuto riflessi importanti sui popolamenti faunistici. L'eliminazione in epoche storiche di gran parte delle foreste che si spingevano in alcuni casi fino al mare e ricoprivano l'intero territorio collinare, la messa a coltura di quasi tutte le terre accessibili fino a quote relativamente elevate ha fatto sì che molte specie faunistiche, soprattutto quelle più esigenti dal punto di vista ecologico, siano scomparse oppure abbiano dovuto rifugiarsi in aree marginali, dove le attività antropiche risultavano meno pressanti. L'estinzione e la rarefazione di molte specie sono state causate, oltre che dalle modifiche degli habitat, anche dalle pressanti persecuzioni subite nel corso dei secoli in quanto rappresentavano concorrenti diretti dell'uomo nelle attività produttive soprattutto in l'agricoltura e nella pastorizia. Non si dimentichi, tra l'altro, che in alcuni periodi storici la fauna selvatica ha rappresentato per le stentate economie rurali una fonte supplementare e talvolta unica di proteine con cui integravano parzialmente le diete costituite esclusivamente di componenti vegetali. Anche in questo senso va letto l'editto del '500 promulgato dai Brancaleoni a salvaguardia delle specie pregiate che popolavano l'Appennino " Nessuno ardisca in Montenerone e sue appendici pigliar caprioli né cotornici, né uccelli rapaci e cioè sparvieri, falconi, astori, terzuoli sotto pena di dieci scudi per ciascun capriolo o uccello rapace, e di uno scudo per ciascuna cotornice" Nonostante alcuni divieti, che però hanno riguardato aree ristrette del territorio regionale, molte specie hanno subito forti persecuzioni fino ad anni relativamente recenti. Si pensi solamente che specie come il lupo, l'aquila, i rapaci in generale, il gatto selvatico sono state protette in modo efficace solo pochi decenni fa. Le prime notizie storiche riguardanti la fauna di queste zone, M. Catria e Nerone, iniziano dal '500 e riguardano soprattutto uccelli e mammiferi. Lettere, diari di caccia, editti sono documenti molto interessanti per cercare di ricostruire quello che doveva essere la componente faunistica del territorio nei secoli passati. Risultano interessanti i diari tenuti da Francesco Maria II della Rovere, in cui l'Autore descrive le sue cacce rivolte soprattutto a cervi, caprioli e cinghiali. Di maggiore interesse, anche per le più precise conoscenze che si evincono dalla lettura, sono gli scritti del medico e naturalista di Piobbico Costanzo Felici. Nelle lettere di Costanzo Felici, inviate nel 1563 al medico bolognese Ulisse Aldrovandi, e soprattutto in un piccolo trattato "Cognitione degl'uccelli et animali pertinenti a l'aere" l'Autore riferisce della presenza nell'area del M. Nerone di alcune specie nidificanti per noi oggi assolutamente impensabili: l'avvoltoio Gipeto, il Grifone e il Capovaccaio, il Picchio nero, il Nibbio reale, il Falco pescatore e molte altre specie oggi decisamente rare come il Gufo reale o l'Astore. La parte meridionale delle Marche, dalle notizie che ci giungono da Pietro Capponi (1899), hanno ospitato il Grifone fino circa alla fine del 1800 "rarissimo sulle alte rocce dei nostri Appennini". Di recente ossa attribuite al Grifone sono state ritrovate su una cengia della Gola della Rossa (De Curtis, 1984, in Pandolfi M, Giacchini P., 1995) avvalorando quanto scriveva Costanzo Felici nel 16' secolo. Molto più accurate sono le descrizioni ornitologiche del Conte Guido Falconieri di Carpegna e ugualmente prezioso è il meticoloso lavoro ornitologico e botanico dell'anconetano Luigi Paolucci, oppure di F.H. Giglioli e di V. Gasparini. Sono anche di questi anni, di fine '800, le più importanti raccolte museali rimaste fino ai giorni nostri, come la raccolta Paolucci, conservata oggi presso il Museo di Offagna, nei pressi di Ancona o la raccolta ornitologica di Francesco Vianelli di Sassoferrato e soprattutto quella di T. Salvadori, il quale lasciò a Fermo la più ricca collezione ornitologica regionale. Al termine di queste brevi note possiamo concludere che risalendo indietro nei secoli ritroviamo tracce e testimonianze numerose di specie animali ormai completamente estinte, ma che rimangono in alcuni documenti storici, nei toponimi di alcune località, o nelle leggende popolari locali. Da alcuni anni, tuttavia, le più efficaci misure di protezione della fauna, l'abbandono di ampi settori alto collinari e montani, hanno restituito spazio ad elementi faunistici nei secoli scacciati o relegati in habitat del tutto marginali.
Uccelli presenti ed estinti
Le principali trasformazioni che l'avifauna marchigiana ha subito nei decenni recenti sono imputabili essenzialmente ai cambiamenti ambientali che si sono verificati. Alcune specie hanno seguito tali trasformazioni ambientali modificando parzialmente le proprie abitudini, altre, più esigenti e meno adattabili, sono scomparse.
Le tipologie ambientali più importanti per l'avifauna sono:
a) ambiente coltivato;
b) ambiente rupestre;
c) ambiente forestale;
d) ambiente dei pascoli sommitali;
e) ambiente paludoso.
A queste tipologie ambientali va aggiunto l'ambiente urbano che attrae, oltre le specie tipicamente antropofile, anche alcune specie forestali e para rupestri. Le specie tipicamente antropofile sono il Passero domestico e di più recente acquisizione la Tortora dal collare orientale, arrivata nelle Marche solo dal 1950 (Moltoni, 1954). Ad attrarre alcune specie para rupestri sono soprattutto le strutture degli antichi centri storici, con vecchie abitazioni, cinte murarie, torri e campanili, ambienti analoghi a quelli rupestri con in più abbondanza di risorse trofiche. Hanno trovato insediamento in città piccoli rapaci come il Gheppio, rapaci notturni come la Civetta e il Barbagianni o altre come il Codirosso spazzacamino e soprattutto la Taccola, la cui colonizzazione della città è cosa recente. Viceversa non sono più nidificanti specie come il Passero solitario, il cui nome evoca una famosa lirica di Leopardi, che oltre sommo poeta rileva anche una spiccata capacità di osservazione di elementi naturali, e la cicogna bianca. Parchi, giardini e siepi offrono micro ambienti forestali o ecotonali di cui hanno approfittato moltissime specie, come merli, pettirossi, cince, ecc. In alcuni casi la città viene assunta da alcune specie come vero e proprio dormitorio, è il caso dello Storno, che di giorno si alimenta nelle campagne circostanti. Dal punto di vista ornitologico gli ambienti che hanno subito le maggiori trasformazioni sono l'ambiente boschivo, l'ambiente agricolo e quello palustre; più conservati sono l'ambiente urbano e quello dei pascoli sommitali. L'ambiente coltivato negli ultimi decenni ha subito sensibili modificazioni e con esso in parte anche la struttura delle comunità ornitiche. Siepi, filari e piccole colture hanno lasciato il posto ad estese monocolture sottraendo a molte specie i luoghi idonei alla nidificazione. Inoltre l'uso massiccio di sostanze chimiche, oltre a procurare a molti uccelli e ad altri animali un avvelenamento diretto, sottrae molti insetti che costituiscono la base di alimentazione dei giovani. La meccanizzazione peraltro induce una mortalità molto elevata per quelle specie che nidificano al suolo, come quaglie e starne e albanella minore. Testimonianze storiche attestano la presenza in ambienti agricoli, nei secoli passati, di specie ormai estinte come il Re di quaglie e la Gallina prataiola, quest'ultima relegata ormai con piccole e precarie popolazioni solamente in Puglia e in alcune località della Sardegna. L'ambiente forestale è forse quello che nel corso dei secoli ha subito le più intense trasformazioni sia nell'estensione della copertura forestale sia nella struttura stessa del bosco. Sono scomparse le antiche foreste di alto fusto, sostituite da cedui intensamente sfruttati oppure, almeno fino alle quote in cui le condizioni climatiche lo permettevano, da coltivi. Negli ultimi decenni l'abbandono dei terreni marginali, non più redditizi dal punto di vista agricolo, sta favorendo la ripresa del cespuglieto e del cespuglieto alberato e infine dei boschi. La riforestazione naturale sta di nuovo cambiando l'ambiente sia di alcune aree collinari che dei prati montani secondari. L'importanza per gli uccelli ma anche per altri gruppi faunistici di queste aree prative consolidatesi nei secoli, consiglierebbe un loro mantenimento a pascoli o a praterie secondarie. Indubbiamente le modifiche della struttura forestale hanno influito e non poco sui popolamenti ornitici e sulla possibilità o meno di sopravvivenza delle specie più esigenti. Come si è già scritto, le specie ornitiche che più di altre hanno subito drastici cali rispetto ai secoli passati, almeno a partire dal '500, secolo da cui partono le indicazioni più attendibili, sono state soprattutto quelle di grandi e medie dimensioni, con abitudini forestali. Specie come l'Avvoltoio monaco, il Nibbio bruno, lo Smeriglio, la Colombella, il Picchio nero sono ormai un antico ricordo. Per quanto riguarda il Picchio nero alcune testimonianze lo fanno ritenere presente nel settore meridionale delle Marche fino a circa la metà del '800. Un'altra tipologia ambientale importante è l'ambiente rupestre, ovvero le gole calcaree appenniniche o pre-appenniniche, come la gola di Frasassi, del Furlo, dell'Infernaccio. L'asperità ambientale ha fatto sì che le modifiche subite nei secoli siano state meno consistenti rispetto ad altri ambienti. Malgrado ciò, almeno per la Provincia di Pesaro, dal '500 ad oggi sono scomparse da questi ambienti diverse specie, alcune delle quali si sono spostate nell'ambiente urbano come il Rondone e il Balestruccio, altre sono del tutto scomparse come il Capovaccaio, il Grifone, il Gipeto, il Gufo reale e il Piccione selvatico. Un altro ambiente che nei secoli si è mantenuto relativamente stabile è rappresentato dai prati di alta quota, sia primari che di origine secondaria. Anche se i prati di origine secondaria sono il risultato degli interventi di deforestazione dell'uomo, questi in gran parte sono avvenuti in epoca precedente rispetto ai dati storici in nostro possesso. Ciò che realmente si è modificato è l'uso che l'uomo nei secoli ha fatto di queste aree. Allo sfruttamento strettamente pastorale si è sommato quello turistico, non sempre rispettoso dei delicati equilibri dell'ambiente montano di alta quota. La rete di sentieri per trekking, le strade, come quelle che conducono in alta quota nel M. Catria e M. Sibilla e impianti turistici rappresentano un danno ambientale a volte gravissimo. Specialmente la costruzione di strade (anche forestali) e insediamenti turistici, a quote elevate, sono un triste e indelebile oltraggio realizzati in un periodo che si spera definitivamente tramontato. A conclusione di questa breve panoramica sugli ambienti rilevanti dal punto di vista ornitologico, facciamo cenno ora alle aree umide. Anche se la nostra Regione per la conformazione fisica del territorio, non ha mai avuto estesi ambienti paludosi, certamente nei secoli passati questi occupavano diverse aree prossime alla foce dei fiumi o in altre zone limitrofe al mare. Ben poco rimane oggi. Uniche testimonianze sono gli stagni salmastri a Porto d'Ascoli, alla foce del Tronto, e a Portonovo alle pendici del M. Conero. Gli ambienti umidi sono da un punto di vista edafico ecosistemi estremamente produttivi e perciò rappresentano aree strategiche soprattutto per l'avifauna in migrazione. Malgrado la scomparsa di quasi tutti gli ecosistemi umidi naturali, le attività antropiche ne hanno creati di nuovi, come i laghetti di escavazione di ghiaia, oppure quelli di sversamento delle acque di zuccherifici, con minore valore naturalistico, tuttavia ugualmente importanti dal punto di vista ornitologico. Di questi ne hanno approfittato alcune specie, come dimostrato dalle recenti nidificazioni del Cavaliere d'Italia, negli stagni degli zuccherifici, e di alcuni ardeidi, come la Garzetta, la Nitticora e l'Airone cenerino, in un lago di escavazione lungo il Fiume Esino.
Status attuale
La presente valutazione, fatta sulla base delle conoscenze attuali, è relativa alla situazione delle specie nelle Marche. E' stata presa in considerazione la bibliografia relativa, qui acclusa solo in parte. Per le valutazioni di stato sono state prese in considerazione: la Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, la Convenzione di Bonn relativa alla conservazione delle specie migratrici e la Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. Lo status di conservazione dei singoli taxon è stato definito secondo i criteri IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) e secondo le indicazioni di Birdlife International, con specifico riferimento al testo di Tucker & Heath Birds in Europe-Their Conservation Status. Inoltre si è tenuto conto della Red-list degli uccelli italiani sulla base di criteri IUCN, elaborata da Marco Gustini e da Francesco Petretti e della Lista Rossa dei Vertebrati Italiani, Calvario e Sarrocco 1997, elaborata dal Settore Diversità biologica del WWF Italia. Descriveremo solo le specie più appariscenti e di cui si hanno notizie storiche o sulle quali siano state effettuate delle ricerche. E' stata riportata solo una breve descrizione delle specie CR, critically endangered, e EN endangered. Per le specie appartenenti alle altre categorie sono fornite solo alcune indicazioni più generali.
Categorie considerate
EX - EXTINCT (SPECIE ESTINTA)
Un taxon é estinto quando non vi é alcun ragionevole dubbio che l'ultimo individuo sia morto.
EW - EXTINCT IN THE WILD (SPECIE ESTINTA IN NATURA)
Un taxon é estinto allo stato libero quando rimangono solo individui in cattività o in popolazioni/e naturalizzate e al di fuori dell'areale storico. Un taxon é estinto in natura quando accurate indagini nell'habitat noto o presunto in tempi appropriati e in tutto l'areale storico, non sono riuscite a registrare un solo individuo. Le indagini dovrebbero essere svolte in un arco di tempo appropriato al ciclo biologico del taxon.
CR - CRITICALLY ENDANGERED (SPECIE IN ELEVATO PERICOLO DI ESTINZIONE)
Il taxon è in pericolo critico quando si trova ad un altissimo rischio di estinzione allo stato selvatico nell'immediato futuro estremamente alto.
EN - ENDANGERED - (SPECIE IN PERICOLO DI ESTINZIONE)
Il taxon è in pericolo quando si trova ad un livello molto alto di rischio di estinzione allo stato selvatico in un futuro prossimo.
VU - VULNERABLE - (SPECIE VULNERABILE)
Il taxon è vulnerabile quando non è in pericolo critico o in pericolo, ma si trova ad alto rischio di estinzione allo stato selvatico in un futuro a medio termine.
LR - LOWER RISK - (SPECIE A BASSO RISCHIO DI PERICOLO DI ESTINZIONE)
Il taxon è a basso rischio di estinzione allo stato selvatico in un futuro prossimo ma sono ancora ben evidenti alcuni fattori di rischio
Lista rossa degli uccelli nidificanti e mgratori delle Marche: valutazione di stato degli uccelli
IN PERICOLO IN MODO CRITICO -CR
Albanella minore Circus pygargus CR -
La specie nidificava fino al 1995 in Regione con 25-30 coppie. Oggi nella Regione si sta assistendo ad una trend negativo con sole10-15 coppie nidificanti. La totalità della popolazione è distribuita nella porzione settentrionale della Provincia di Pesaro e Urbino (praticamente nella Valle del Foglia). Da 5 anni non ci sono più casi di nidificazione in ambiente agricolo. L'Albanella minore nidifica al suolo in piccole colonie o anche isolatamente. Nelle Marche vengono utilizzati di preferenza le zone calanchive oppure i campi coltivati a cereali o erba medica della media e bassa collina. Nidificazione in aree di media quota sono state segnalate per il M. Catria e Monte Paganuccio. La causa principale di insuccesso riproduttivo è ricercabile nel disturbo e/o nella distruzione dei nidi durante la trebbiatura, nella predazione da parte di mammiferi terrestri.
Picchio rosso mezzano Picoides medius CR -
E' un Picide di piccole dimensioni che necessita di ecosistemi forestali maturi con alberi o parti di essi marcescenti in cui costruisce il nido e ricerca insetti di cui si nutre. E' una specie molto rara in Italia e in tutto l'areale europeo. Già dal secolo scorso questo piccolo picchio è sempre stato considerato molto raro.Non ci sono studi specifici nella Regione che ne abbiano valutato la fenologia e l'ecologia. Sono scarsissime anche le segnalazioni, recentemente la specie non è stata più osservata. E' stata segnalata nel Bosco di Tecchie presso Cantiano nel 1988 (Tanferna, in Pandolfi e Giacchini 1995).
IN PERICOLO -EN -
Aquila reale Aquila chrysaetos EN -
E' il più grande uccello rapace presente stabilmente nella Regione. L'habitat è costituito dall'ambiente montano con pareti rocciose e gole rupestri in cui costruisce il nido. La prolificità dell'aquila reale è estremamente bassa; da uno studio effettuato da Ragni et al. 1986, su 26 coppie controllate nel periodo 1979-83 la produttività media è stata di 0,61.Depone uno-due uova, ma normalmente un solo giovane arriva a svilupparsi fino ad abbandonare il nido. E' attiva e caccia in pieno giorno in quanto, date le grandi dimensioni, utilizza per spostarsi il volo planato sfruttando le corrente ascensionali. Si nutre di mammiferi, uccelli e rettili dalle dimensioni di un topo fino ai piccoli di cinghiale oltre che di carogne. Le coppie sono fedeli al territorio e ai siti di nidificazione in esso presenti. Si stima che il nido presente nella Gola del Furlo possa avere, date le sue dimensioni, centinaia e forse migliaia di anni (Pandolfi & Giacchini 1995). Gli individui che formano la coppia rimangono uniti per tutta la vita. Il legame viene ogni anno rinsaldato da spettacolari voli di corteggiamento. Dopo gli anni 70, quando le coppie nidificanti presenti in Regione non erano più di 7, la situazione è leggermente migliorata e oggi abbiamo circa 10 coppie nidificanti.
Nibbio reale Milvus milvus - EN -
Le notizie storiche fanno ritenere che fino al secolo scorso la specie doveva essere relativamente comune nella Regione, ma già dall'inizio del secolo, Pietro Zangheri (1938) lo considerava raro per la limitrofa Emilia Romagna. Attualmente il Nibbio reale è estinto come nidificante ma è oggetto di un progetto di reintroduzione nel Parco Regionale della Gola della Rossa da parte del WWF e dell'Università di Urbino.
Astore Accipiter gentilis - EN - Le testimonianze storiche fanno ritenere l'Astore ben presente in Regione nei secoli passati. Attualmente la specie è molto rara con complessivamente forse non più di 10 coppie nidificanti nella Regione.Per la nidificazione predilige boschi di alto fusto inframezzati da radure dove va alla ricerca di prede che possono raggiungere le dimensioni di una lepre.
Biancone Circaetus gallicus - EN -
Rapace di medio-grandi dimensioni che preda soprattutto rettili. Pochissime coppie nidificanti in Regione, una certa anche in Provincia di Pesaro.
Lanario Falco biarmicus feldeggii - EN -
E' un rapace che esibisce in volo una notevole agilità. Le Marche rappresentano il limite settentrionale dell'areale di distribuzione. Per questo motivo il numero di coppie nidificanti nella Regione è maggiore nel settore meridionale, 8-9 coppie, viceversa nella Provincia di Pesaro il numero di coppie nidificanti non supera 1 o 2.
Gufo reale Bubo bubo - EN -
E' il più grande rapace notturno italiano. E' una specie molto elusiva che necessiterebbe di adeguate ricerche anche utilizzando strumenti sonori per stimarne l'effettiva distribuzione nei territori e la consistenza numerica. Il forte calo subito dalla specie nei decenni passati è da ricercare nelle campagne di persecuzione che molti uccelli rapaci hanno subito perché considerati erroneamente nocivi e nell'elevata mortalità dovuta all'impatto con i fili degli elettrodotti. La specie è presente nella Regione con pochissime coppie, disperse e poco localizzate.
Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus - EN -
E' una specie assai simile, sia come aspetto che come ambienti frequentati, al Gracchio corallino che al contrario ha una più ampia distribuzione pur localizzata nelle aree più elevate. Il becco giallo ricurvo che contrasta con il corpo nero metallico lo contraddistingue dal congenere Gracchio corallino il cui becco è rosso. Frequenta prati e pascoli di alta quota, generalmente in gruppo, volteggiando ed esibendosi in voli acrobatici anche in condizioni meteorologiche proibitive. La specie è presente nel solo Parco Nazionale dei Monti Sibillini con una popolazione molto ridotta e in trend negativo.
Fringuello alpino Montifringilla nivalis - EN -
Presente nei soli Monti Sibillini con una piccola popolazione isolata e molto poco studiata.
VULNERABILE -VU-
Tarabusino Ixobrychus minutus - VU -
Nidificazione scarsa e localizzata in poche zone umide marchigiane.
Garzetta Egretta garzetta - VU -
Nidificante nell'oasi WWF Ripabianca di Jesi, lungo il fiume Esino, dal 1994 con poche coppie.
Airone cenerino Ardea cinerea - VU -
Nidificante nell'oasi WWF Ripabianca di Jesi dal 1998 con poche coppie. Vulnerabile come nidificante, la specie è relativamente abbondante come estivante e svernante.
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus - VU -
Nidifica nella zona montana della fascia appenninica. Popolazione censita molto scarsa.
Lodolaio Falco subbuteo - VU -
La specie nidifica nella aree collinari e montane della Regione con poche coppie localizzate. Piuttosto difficile da individuare, status poco conosciuto.
Falco pellegrino Falco pereginus - VU -
La specie è presente nelle Marche con alcune decine di coppie riproduttive. Negli ultimi anni è in buona ripresa. Gufo comune Asio otus - VU - Nidificazione diffusa nella Regione, ma scarsa.
Succiacapre Caprimulgus europaeus - VU -
Diffuso in area montana e collinare, nidificazione scarsa.
Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax - VU - La specie è presente nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e nel massiccio del Monte Catria. Popolazione ridotta ma stabile.
Coturnice - VU - Ditribuzione ridotta a causa della persecuzione venatoria. Oggi presente solo nel massiccio del Catria - Nerone e nel Parco Nazionale dei Sibillini. Scarso numero di coppie.
Porciglione Rallus acquaticus - VU - Nidificazione sporadica tra i canneti lungo i fiumi e negli stagni artificiali.
Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus - VU -
Nidificazione sporadica nei bacini di raccolta delle acque degli zuccherifici di Jesi e talvolta fin quando in attività in quello di Fano.
Gruccione Merops apiaster - VU - Nidificazione localizzata a pochissimi siti nella Regione. Frequenta ambienti perifluviali.
Picchio muraiolo Tichodroma muraria - VU - Nidificazione localizzata in pochissimi siti nella Regione. Frequenta pareti rocciose della catena appenninica. E' stato osservato anche sulle pareti calcaree a ridosso del mare nel M.Conero al di fuori del periodo riproduttivo.
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus - VU - Nidifica nei corsi d'acqua appenninici. Distribuzione ridotta e relegata alla zona montana.
Topino Riparia riparia - VU - Nidifica in colonie in alcune scarpate friabili in cui scava buchi e costruisce il nido. In trend negativo in tutta Italia così pure nelle Marche.
Spioncello Anthus spinoletta - VU - A diffusione ridotta e legato all'area alto montana.
Sordone Prunella collaris - VU - A diffusione ridotta e legato all'area alto montana.
Monachella Oenanthe hispanica - VU - Rara e localizzata, legata ad ambienti aridi.
Balia dal collare Ficedula albicollis - VU - Poche nidificazioni accertate. Monti della Laga.
Averla capirossa Lanius senator - VU - Un tempo abbondante ora in fortissimo trend negativo.
Ortolano Emberiza hortulana - VU -
Presente in Regione con popolazioni localizzate e poco abbondanti.
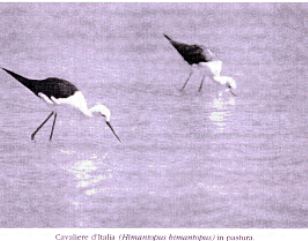
Specie di uccelli presenti nella regione solo come migratori, svernanti o di presenza irregolare ma inseriti in categorie di rischio molto elevate in Europa: CR, EN, VU
Rispetto a queste specie andrebbero valutate le aree preferenziali di migrazione: valichi montani, valli fluviali, coste alte e rocciose (come quelle del Conero e della falesia tra Gabicce e Pesaro) e quelle di svernamento: zone umide, pianure poco antropizzzate, pascoli montani, al fine di ridurre disturbo, pericoli e bracconaggio.
Airone bianco maggiore Egretta alba
Airone rosso Ardea purpurea
Cicogna nera Ciconia nigra
Mignattaio Plegadis falcinellus
Spatola Platalea leucorodia
Volpoca Tadorna tadorna
Canapiglia Anas strepera
Fistione turco Netta rufina
Moretta tabaccata Aythya niroca
Moretta Aythya fuligula
Pesciaiola Mergus albellus
Smergo minore Mergus serrator
Smergo maggiore Mergus merganser
Grifone Gyps fulvus
Capovaccaio Neophron percnopterus
Falco di palude Circus aeruginosus
Albanella reale Circus cyaneus
Poiana calzata Buteo lagopus
Aquila anatraia maggiore Aquila clanga
Aquila del Bonelli Hieraaetus fasciatus
Grillaio Falco naumanni
Falco cuculo Falco vespertinus
Falco pescatore Pandion haliaetus
Gru Grus grus
Beccaccia di mare Haematopus ostralegus
Avocetta Recurvirostra avosetta
Piviere tortolino Eudromias morinellus
Voltolino Porzana porzana
Occhione Burhinus oedichnemus
Pittima minore Limosa lapponica
Chiurlo piccolo Numenius phaeopus
Beccaccia Scolopax rusticola
Pettegola Tringa totanus
Piro piro piccolo Actitis hypoleuca
Sterna maggiore Sterna caspia
Sterna zampenere Gelichelidon nilotica
Mignattino piombato Chlidonias hybridus
Mignattino Chlydonias niger
Mignattino alibianche Chlydonias leucopterus
Gufo di palude Asio flammeus
Colombella Columba oenas
Rondine rossiccia Hirundo daurica
Ghiandaia marina Coracias garrulus
Averla cenerina Lanius minor
Averla maggiore Lanius excubitor
Bigia grossa Sylvia hortensis
Check-list degli uccelli delle Marche
Una Check-list costituisce un primo strumento conoscitivo indispensabile sulla presenza-assenza di una specie di una certa unità tassonomica di un'area geografica. Anche se una check-list appare una elencazione asettica sulle diverse specie, in realtà è il risultato di un lungo lavoro di ricerca per tentare di mettere insieme le prime ma indispensabili conoscenze relative ad un gruppo tassonomico di un territorio. Una check-list è un punto di partenza, non certamente un punto di arrivo delle conoscenze di un territorio. Le specie cambiano continuamente la propria corologia, per i motivi più vari, alcune possono scomparire da un territorio, altre ricomparire oppure modificare il proprio status. Questa lista è stata elaborata seguendo i metodi della check-list degli uccelli italiani di Brichetti & Massa (1984). Vengono quindi similmente adottati i criteri tassonomici di Voous e Glutz von Blotzheim e al.; le specie non sono trattate utilizzando il rango sottospecifico per le difficoltà di considerare anche questa categoria tassonomica. Nella lista sono state considerate anche le specie rilevate dalla bibliografia recente relativa a circa gli ultimi venti anni. A fianco del nome è indicato lo stato fenologico della specie nelle Marche secondo la seguente legenda dei simboli usati:
B = Nidificante (Breeding)
S = Stazionaria o Sedentaria (Sedentary, Resident)
M = Migratrice (Migratory)
W = Svernante o Invernale (Wintering or Winter visitor)
A = Accidentale (Accidental or Vagant)
reg = regolare (regular)
irr = irregolare (irregular)
par = parziale (partial)
? = può seguire ogni simbolo con significato di dubbio.
GAVIIFORMES
Gaviidae
Strolaga mezzana Gavia arctica (Linnaeus): M reg
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Tuffetto Tachybaptes ruficollis (Pallas): W,B, M reg Svasso maggiore Podiceps cristatus (Linnaeus): SB, M reg Svasso piccolo Podiceps nigricollis C. L. Brehm: M reg, W
PROCELLARIIFORMES
Procellaridae
Berta maggiore Calonectris diomedea (Scopoli): W par, M reg Berta minore Puffinus puffinus (Brunnich): W, M par
PELECANIFOMES
Sulidae
Sula Sula bassana (Linnaeus): M reg
Phalacrocoracidae
Cormorano Phalacrocorax carbo (Linnaeus): M reg, W Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus): M irr
CICONIIFORMES
Ardeidae
Tarabuso Botaurus stellaris (Linnaeus): M reg, W par Tarabusino Ixobrychus minutus (Linnaeus): M reg, B Nitticora Nyctycorax nyctycorax (Linnaeus): M reg, B Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides (Scopoli): M reg Garzetta Egretta garzetta (Linnaeus): M reg, B Airone bianco maggiore Egretta alba (Linnaeus): M reg Airone cenerino Ardea cinerea Linnaeus: M reg, W, B Airone rosso Ardea purpurea Linnaeus: M reg
Ciconiidae Cicogna nera Ciconia nigra (Linnaeus): M reg Cicogna bianca Ciconia ciconia (Linnaeus): M reg Threskiornitidae
Mignattaio Plegadis falcinellus (Linnaeus): M reg Spatola Platalea leucorodia Linnaeus: M reg
ANSERIFORMES
Anatidae
Cigno selvatico Cygnus cygnys (Linnaeus): M reg, W Oca granaiola Anser fabalis (Latham): M reg Oca lombardella Anser albifrons (Scopoli): M reg Oca selvatica Anser anser (Linnaeus): M reg, W Volpoca Tadorna tadorna (Linnaeus): M reg Fischione Anas penelope Linnaeus: M irr Canapiglia Anas strepera Linnaeus: M reg Alzavola Anas crecca Linnaeus: M reg, Germano reale Anas platyrhynchos Linnaeus: M reg, W, SB Codone Anas acuta Linnaeus: M reg Marzaiola Anas querquedula Linnaeus: M reg, B Mestolone Anas clypeata Linnaeus: M reg Moriglione Aythya ferina (Linnaeus): M reg, W Moretta tabaccata Aythya nyroca (Guldenstadt): M reg Moretta Aythya fuligula (Linnaeus): M reg, W Edredone Somateria mollissima (Linnaeus): M reg Quattrocchi Bucephala clangula (Linnaeus): M irr Pesciaiola Mergus albellus Linnaeus: A Smergo minore Mergus serrator Linnaeus: M reg, W Smergo maggiore Mergus merganser Linnaeus: A
ACCIPITRIFORMES
Accipritridae
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (Linnaeus) M reg, B Nibbio bruno Milvus migrans (Boddaert): M reg Nibbio reale Milvus milvus (Linnaeus): S, W par Aquila di mare Haliaeetus albicilla (Linnaeus): A Biancone Circaetus gallicus (Gmelin): M reg, B Falco di palude Circus aeruginosus (Linnaeus): M reg, W par Albanella reale Circus cyaneus (Linnaeus): M reg, W Albanella minore Circus pygargus (Linnaeus): M reg, B Astore Accipiter gentilis (Linnaeus): SB, M reg, W par Sparviere Accipiter nisus (Linnaeus): SB, M reg, W Poiana Buteo buteo (Linnaeus): SB, M reg, W Poiana calzata Buteo lagopus (Pontoppidan): M irr Aquila anatraia maggiore Aquila clanga Pallas: A Aquila reale Aquila chrysaetos (Linnaeus): SB, M irr Aquila del Bonelli Hieraaetus fasciatus (Vieillot): A
Pandionidae Falco pescatore Pandion haliaetus (Linnaeus): M reg
FALCONIFORMES
Falconidae
Gheppio Falco tinnunculus Linnaeus: SB, M reg, W Falco cuculo Falco vespeertinus Linnaeus: M reg Lodolaio Falco subbuteo Linnaeus: M reg, B Lanario Falco biarmicus Temminck: SB, M reg? Pellegrino Falco peregrinus Tunstall: SB, M reg, W par
GALLIFORMES
Phasianidae Coturnice Alectoris graeca (Meisner): SB Starna Perdix perdix (Linnaeus): SB Quaglia Coturnix coturnix (Linnaeus): B, M reg, W par Fagiano comune Phasianus colchicus Linnaeus: SB
GRUIFORMES
Rallidae
Porciglione Rallus aquaticus Linnaeus: SB, M reg, W par Gallinella d'acqua Gallinula chloropus (Linnaeus): SB, M reg, W Folaga Fulica atra Linnaeus: M reg, W, B
Gruidae
Gru Grus grus (Linnaeus): M reg
CHARADRIFORMES
Hematopodidae
Beccaccia di mare Haematopus ostralegus Linnaeus: M reg
Recurvirostridae
Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus (Linnaeus): SB, M reg, W par Avocetta Recurvirostra avosetta Linnaeus: M reg, B
Burhinidae
Occhione Burhinus oedicnemus (Linnaeus): M reg, B?
Glareolidae
Corrione biondo Cursorius cursor (Latham): A Pernice di mare Glareola pratincola (Linnaeus): M reg
Charadriidae
Corriere piccolo Charadrius dubius Scopoli: M reg, W irr, B Corriere grosso Charadrius hiaticula Linnaeus: M reg Fratino Charadrius alexandrinus Linnaeus: M reg, W par, B Piviere tortolino Eudromias morinellus (Linnaeus): M reg, B Piviere dorato Pluvialis apricaria (Linnaeus): M reg, W Pivieressa Pluvialis squatarola (Linnaeus): M reg, W par Pavoncella Vanellus vanellus (Linnaeus): M reg, W
Scolopacidae
Piovanello tridattilo Calidris alba (Pallas): M reg, W par Gambecchio Calidris minuta (Leisler): M reg, W Piovanello Calidris ferruginea (Pontoppidan): M reg Piovanello pancianera Calidris alpina (Linnaeus): M reg Combattente Philomachus pugnax (Linnaeus): M reg, W par Beccaccino Gallinago gallinago (Linnaeus): M reg Croccolone Gallinago media (Latham): M irr Beccaccia Scolopax rusticola (Linnaeus): M reg, W Pittima reale Limosa limosa (Linnaeus): M reg Pittima minore Limosa lapponica (Linnaeus): M reg Chiurlo piccolo Numenius phaeopus (Linnaeus): M reg Chiurlo maggiore Numenius arquata (Linnaeus): M reg Totano moro Tringa erythropus (Pallas): M reg Pettegola Tringa totanus (Linnaeus): M reg Albastrello Tringa stagnatilis (Bechstein): M irr Pantana Tringa nebularis (Gunnerus): M reg Piro piro culbianco Tringa ochropus (Linnaeus): reg, W par Piro piro boschereccio Tringa glareola (Linnaeus): M reg Piro piro piccolo Actitis hypoleucos (Linnaeus): M reg, W B Voltapietre Arenaria interpres (Linnaeus): M reg, W par Falaropo beccolargo Phalaropus fulicarius (Linnaeus): A
Stercorariidae
Labbo Stercorarius parasiticus (Linnaeus): M reg
Laridae
Gabbiano corallino Larus melanocephalus Temminck: M reg, W Gabbianello Larus minutus Pallas: M reg Gabbiano comune Larus ridibundus Linnaeus: M reg, W Gavina Larus canus Linnaeus: M reg, W Zafferano Larus fuscus Linnaeus: M reg, W Gabbiano reale nordico Larus argentatus Pontoppidan: M irr, W par Gabbiano reale Larus cachinnans Pallas: M reg, W Mugnaiaccio Larus marinus Linnaeus: M irr Gabbiano tridattilo Rissa tridactyla Linnaeus: M reg, W
Sternidae
Sterna zampenere Gelochelidon nilotica (Gmelin): M reg Sterna maggiore Sterna caspia Pallas: M reg Beccapesci Sterna sandvicensis Latham: M reg Sterna comune Sterna hirundo Linnaeus: M reg Fraticello Sterna albifrons Pallas: M reg Mignattino piombato Chlidonias hybridus (Pallas): M reg Mignattino Chlydonias niger Linnaeus: M reg Mignattino alibianche Chlydonias leucopterus (Temminck): M reg
COLUMBIFORMES
Columbidae
Piccione selvatico Columba livia Gmelin: SB? Colombella Columba oenas Linnaeus: M reg, W Colombaccio Columba palumbus Linnaeus: SB, M reg, W Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto Frivaldszky: SB Tortora Streptopelia turtur Linnaeus: M reg, B
CUCULIFORMES
Cuculidae
Cuculo Cuculus canorus Linnaeus: M reg, B
STRIGIFORMES
Tytonidae
Barbagianni Tyto alba (Scopoli): SB, M par Strigidae Assiolo Otus scops (Linnaeus): B, W par, M reg Gufo reale Bubo bubo (Linnaeus): SB Civetta Athene noctua (Scopoli): SB, M reg, W par Allocco Strix aluco Linnaeus: SB, M par Gufo comune Asio otus Linnaeus: M reg, W, B Gufo di palude Asio flammeus (Pontoppidan): M irr
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Succiacapre Caprimulgus europaeus Linnaeus: M reg, B
APODIFORMES
Apodidae
Rondone Apus apus (Linnaeus): M reg, B Rondone pallido Apus pallidus (Shelley): M reg, B Rondone maggiore Apus melba (Linnaeus): M reg, B
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Martin pescatore Alcedo atthis (Linnaeus): SB, M reg, W
Meropidae
Gruccione Merops apiaster Linnaeus: M reg, B
Coraciidae
Ghiandaia marina Coracias garrulus Linnaeus: M reg
Upupidae
Upupa Upupa epops Linnaeus: M reg, B
PICIFORMES
Picidae
Torcicollo Jynx torquilla Linnaeus: M reg, B Picchio verde Picus viridis Linnaeus: SB, M irr Picchio rosso maggiore Picoides mayor (Linnaeus): SB M par, W Picchio rosso minore Picoides minor (Linnaeus): SB
PASSERIFORMES
Alaudidae
Calandra Melanocorypha calandra (Linnaeus): M par Calandrella Calandrella brachydactyla (Leisler): M reg, B Cappellaccia Galerida cristata (Linnaeus): SB, M irr Tottavilla Lullula arborea (Linnaeus): SB, M reg Allodola Alauda arvensis Linnaeus: SB, M reg, W
Hirundinidae
Topino Riparia riparia (Linnaeus): M reg, B Rondine montana Ptyonoprogne rupestris (Scopoli): B, W par, M reg Rondine Hirundo rustica Linnaeus: M reg, B Rondine rossiccia Hirundo daurica Linnaeus: M irr Balestruccio Delichon urbica (Linnaeus): M reg, B
Motacillidae
Calandro maggiore Anthus novaeseelandiae (J. F. Gmelin): M irr Calandro Anthus campestris (Linnaeus): M reg, B Prispolone Anthus trivialis (Linnaeus): M reg, B Pispola Anthus pratensis (Linnaeus): M reg, W Pispola golarossa Anthus cervinus (Pallas): M reg Spioncello Anthus spinoletta (Linnaeus): B, W, M reg Cutrettola Motacilla flava Linnaeus: M reg, B Ballerina gialla Motacilla cinerea Tunstall: SB, M reg, W Ballerina bianca Motacilla alba Linnaeus: SB, M reg, W
Bombycillidae
Beccofrusone Bombicilla garrulus (Linnaeus): invasivo
Cinclidae
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus (Linnaeus): SB, M reg, W Troglodytidae Scricciolo
Troglodytes
troglodytes (Linnaeus): SB, M reg, W
Prunellidae
Passera scopaiola Prunella modularis (Linnaeus): B, W, M reg Sordone Prunella collaris (Scopoli): SB, M reg, W
Turdidae
Pettirosso Erithacus rubecola (Linnaeus): SB, M reg, W Usignolo Luscinia megarhynchos C. L. Brehm: M reg, B Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochrurus (S. C. Gmelin): B, W par, M reg Codirosso Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus): M reg, B Stiaccino Saxicola rubetra (Linnaeus): M reg, B Saltimpalo Saxicola torquata (Linnaeus): SB, M reg, W Culbianco Oenanthe oenanthe (Linnaeus): M reg, B Monachella Oenanthe hispanica (Linnaeus): M reg Codirossone Monticola saxatilis (Linnaeus): M reg, B Passero solitario Monticola solitarius (Linnaeus): SB, M par, W Merlo dal collare Turdus torquatus Linnaeus: M reg, B? Merlo Turdus merula Linnaeus: SB, M reg, W Cesena Turdus pilaris Linnaeus: M reg, W Tordo battaccio Turdus philomelos C. L. Brehm: M reg, W, B Tordo sassello Turdus iliacus Linnaeus: M reg, W Tordela Turdus viscivorus Linnaeus: SB, M reg
Sylviidae
Usignolo di fiume Cettia cetti (Temminck): SB, W Beccamoschino Cistocala yuncidis (Rafinesque): SB, W? Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon (Temminck): M reg, W, B? Forapaglie Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus): M reg Cannaiola Acrocephalus scirpaceus (Hermann): M reg, B Cannareccione Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus): M reg, B Canapino Hippolais polyglotta (Vieillot): M reg, B Magnanina Sylvia undata (Boddaert): A Sterpazzolina Sylvia cantillans (Pallas): M reg, B Occhiocotto Sylvia melanecaphala (J. F.Gmelin): SB, W par Bigia grossa Sylvia hortensis (J. F. Gmelin): M reg, B Bigia padovana Sylvia nisoria (Bechstein): M reg Sterpazzola Sylvia communis Latham: M reg, B Beccafico Sylvia borin (Boddaert): M reg, B Capinera Sylvia atricapilla (Linnaeus): SB, M reg, W Luì bianco Phylloscopus bonelli (Vieillot): M reg, B Luì verde Phylloscopus sibilatrix (Bechestein): M reg, B Luì piccolo Phylloscopus collybita (Viellot): M reg,B Luì grosso Phylloscopus trochilus (Linnaeus): M reg Regolo Regulus regulus (Linnaeus): SB, M reg, W Fiorrancino Regulus ignicapillus (Temminck):SB,M reg, B
Muscicapidae
Pigliamosche Muscicapa striata (Pallas): M reg, B Balia dal collare Ficedula albicollis (Temminck): M reg, B Balia nera Ficedula hypoleuca (Pallas): M reg,
Aegithalidae
Codibugnolo Aegithalos caudatus Linnaeus: SB, M par, W
Paridae
Cincia bigia Parus palustris Linnaeus: SB, M par, W Cincia mora Parus ater Linnaeus: SB, M par, W Cinciarella Parus caeruleus Linnaeus: SB, M par, W Cinciallegra Parus mayor Linnaeus: SB, M par, W
Sittidae
Picchio muratore Sitta europaea Linnaeus: SB, M par, W
Tichodromadidae
Picchio muraiolo Tichodroma muraria (Linnaeus): SB, M par, W
Certhiidae
Rampichino Certhia brachydactyla C. L. Brehm: SB, M reg, W
Remizidae
Pendolino Remiz pendulinus (Linnaeus): SB, M reg
Oriolidae
Rigogolo Oriolus oriolus (Linnaeus): M reg, B
Laniidae
Averla piccola Lanius collurio Linnaeus: M reg, B Averla cenerina Lanius minor J. F. Gmelin: M irr Averla maggiore Lanius excubitor Linnaeus: M irr (?) Averla capirossa Lanius senator Linnaeus: M reg, B
Corvidae
Ghiandaia Garrulus glandarius (Linnaeus): SB, M par, W Gazza Pica pica (Linnaeus): SB, M irr Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus Linnaeus: SB Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus): SB Taccola Corvus monedula Linnaeus: SB, M irr Cornacchia Corvus corone cornix Linnaeus: SB, M irr, W par Corvo imperiale Corvus corax Linnaeus: A
Sturnidae
Storno Sturnus vulgaris Linnaeus: SB, M reg, W Storno roseo Sturnus roseus (Linnaeus): A
Passeridae
Passera Passer domesticus (Linnaeus): SB, M par (inclusa Passera d'Italia Passer italiae) Passera mattugia Passer montanus (Linnaeus): SB, M reg, W Passera lagia Petronia petronia (Linnaeus): SB?, M par Fringuello alpino Montifringilla nivalis (Linnaeus): SB
Fringillidae
Fringuello Fringilla coelebs Linnaeus: SB, M reg, W Peppola Fringilla montifringilla Linnaeus: M reg, W Verzellino Serinus serinus (Linnaeus): SB, M reg, W Verdone Carduelis chloris (Linnaeus): SB, M reg Cardellino Carduelis carduelis (Linnaeus): SB, M reg, W Lucarino Carduelis spinus (Linnaeus): B irr, M irr Fanello Carduelis cannabina (Linnaeus): M irr Organetto Carduelis flammea (Linnaeus): M irr Crociere Loxia curvirostra Linnaeus: M irr, B irr Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus): SB, M par, W Frosone Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus): M reg, W par
Emberizidae
Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis (Linnaeus): M irr Zigolo giallo Emberizia citrinella Linnaeus: B, W par, M par Zigolo nero Emberiza cirlus Linnaeus: SB, M reg, W par Zigolo muciatto Emberiza cia Linnaeus: SB, M reg, W Ortolano Emberiza hortulana Linnaeus: M reg, B Migliarino di palude Emberiza schoeniclus Linnaeus: M Strillozzo Miliaria calandra Linnaeus: SB, M reg; W par reg, B
Mauro Furlani, Massimo Pandolfi
Bibliografia
AA.VV.1990 - I monti del Furlo. Regione Marche, Comunità Montane Alto Metauro, Alto e Medio Metauro, Catria e Nerone. Ed. Fortuna, Fano.
BORIONI M., 1993 - I rapaci del Conero. Parco del Conero, Ancona. BRICHETTI P. & MASSA B., 1984 - Check-list degli uccelli italiani. Riv. It. Orn. 54: 3-37
CALVARIO E. & SARROCCO S., 1997- Lista Rossa dei Vertebrati italiani. A cura di: Settore Diversità Biologica WWF. DIONISI V. 1993 - Nidificazione del Fratino, Charadrius alexandrinus nelle Marche. Riv. It. Orn. 63 (1) 77-78. DIONISI V. & L. POGGIANI 1982 - L'avifauna del Metauro. Osservazioni condotte nel basso corso del Metauro nel periodo 1980-82. Collana di Educazione Ambientale Centro Studi Argonauta, WWF, Fano.
FELICI C.,1982 - Lettere a Ulisse Aldrovandi.- a cura di G. Nonni. Ed. Quattroventi. Urbino.
GASPARINI V., 1894 - Avifauna marchigiana. Premiata Società Tipografica Cooperativa, Fano.
FURLANI M., 1990 - Primo accertamento della nidificazione della Nitticora, Nycticorax nycticorax, nelle Marche, Riv. It. Orn.,60(1-2): 91-93.
FURLANI M., 1990 - Avifauna del Monte Conero. - Risultati di un primo anno di ricerca. Provincia di Ancona. Ancona.
FURLANI M., 1994 - Accrescimento della garzaia di nitticore (Nycticorax nycticorax) e nidificazione di Garzetta (Egretta garzetta) nelle Marche. Riv. It. Orn. 64(2), 165- 168.
FURLANI M., 1994 - L'avifauna nidificante nella Selva di Castelfidardo (Ancona, Italia Centrale). Atti VII Conv. Naz. Ornitologia, Suppl. Ric. Biol. Selv., XXII 613-615.
MANZI A., & P. PERNA, 1992 - L'avifauna nidificante nelle Marche tra'800 e '900. Proposte e ricerche, 26 (1) :284-298.
MANZI A. & PERNA P., 1992 - I falconi Lanario e Pellegrino nelle Marche centro-meridionali. Natura e Montagna, 35: 29-34.
MOLTONI E., 1954 - La Tortora dal collare orientale -Streptopelia decaocto decaocto (Frivaldszky)-in Italia. Riv. It. Orn., 24: 147-158.
PANDOLFI M. & FRUGIS S., - 1987. Check-list degli uccelli delle Marche. Riv. It. Orn., 57 (3-4) 221-237.
PANDOLFI M. & GIACCHINI P.,1995 - Avifauna nella Provincia di Pesaro e Urbino Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino.
PANDOLFI M. & GIULIANI A., 1993 - Note storiche sulla fauna delle Marche. Biogeographia, vol. XVII: 1-15.
PANDOLFI M. & FURLANI M., 2000 - Note sulle emergenze faunistiche delle Marche. In FURLANI M. Il Paesaggio delle Marche - Passato remoto e presente. Liceo Scientifico "G.Torelli", Pergola. Metauro Edizioni s.n.c. 2000 Fossombrone.
TUCKER G.M. & HEATH M. F., 1994 - Birds in Europe. Their Conservation Status. Birdlife Conservation Series No. 3.